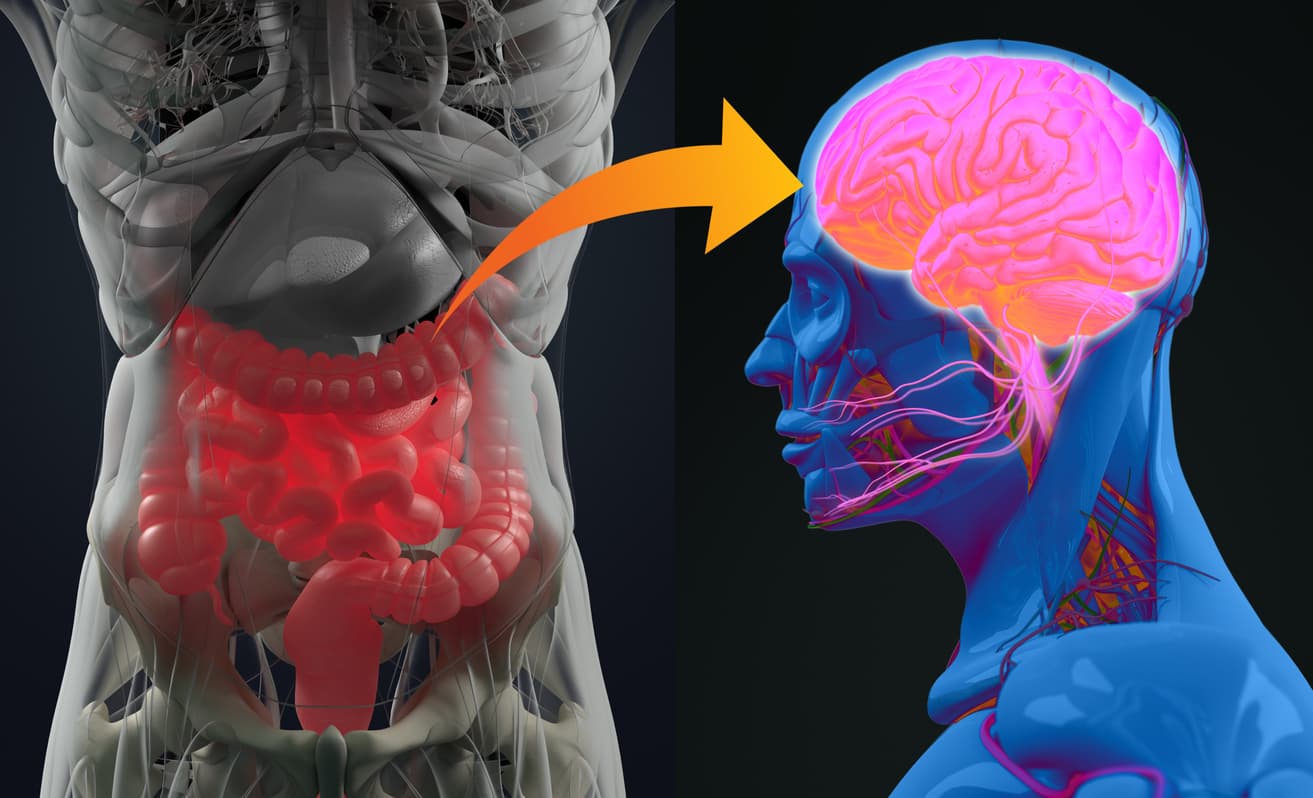RESISTENZA E RECUPERO: I VERI ALLEATI DELLA TUA PERFORMANCE
La performance è più di un gesto atletico
Quando si parla di performance sportiva, il pensiero corre subito a gesti potenti e spettacolari: un sollevamento olimpico, uno sprint esplosivo, una schiacciata a canestro. Ma la vera performance non nasce solo nel momento dell’azione. Bensì è il risultato di un insieme di fattori fisiologici e metodologici che si costruiscono giorno dopo giorno.
Tra questi, la resistenza e il recupero rappresentano due pilastri spesso sottovalutati, ma determinanti per l’evoluzione di qualsiasi atleta (dal bodybuilder al maratoneta).
Un fisico forte ma incapace di sostenere alti volumi di lavoro, o cronicamente stanco per mancanza di recupero, è destinato a fermarsi ben prima di esprimere il suo massimo potenziale.
Perché il sistema aerobico è cruciale anche negli sport di potenza
La resistenza non riguarda solo chi corre una maratona. Un sistema aerobico efficiente migliora la capacità del corpo di:
- Trasportare ossigeno ai muscoli tramite un aumento della gittata cardiaca e della densità capillare.
- Produrre energia ossidativa nei mitocondri, riducendo l’accumulo di lattato e migliorando la capacità di sostenere sforzi ripetuti.
- Recuperare più rapidamente tra una serie e l’altra, fondamentale anche per chi fa sollevamento pesi (powerlifting, weightlifting o bodybuilding) o allenamenti metabolici ad alta intensità.
Pensiamo a un bodybuilder: durante un allenamento di un certo effort, una migliore capacità aerobica permetterà all’atleta di mantenere alto il numero di ripetizioni e tonnellaggio costante anche nelle ultime serie, aumentando il volume totale di lavoro (il che darà come input uno stimolo ipertrofico).
Come allenare la resistenza senza compromettere la forza
Molti atleti che mirano all’aumento di massa muscolare temono che il lavoro aerobico riduca i guadagni di forza o ipertrofia. In realtà, se programmato correttamente, diventa un alleato a lungo termine efficace e che promuove maggior efficienza di lavoro in sala pesi. Esistono però delle peculiarità importanti a riguardo, distinguendo ciò che viene definito lavoro cardiovascolare a basso impatto sistemico e quello ad alto impatto sistemico.
1. Lavoro aerobico a bassa intensità (LISS)
Il Low Intensity Steady State (LISS) rappresenta un approccio essenziale per sviluppare la base aerobica senza compromettere i processi anabolici. Attività come camminate veloci, corsa leggera o ciclismo a ritmo costante per 30-60 minuti, 2-4 volte a settimana, favoriscono un incremento della densità mitocondriale e un miglioramento dell’efficienza ossidativa muscolare. Il vantaggio fisiologico principale risiede nella stimolazione della biogenesi mitocondriale attraverso l’attivazione della proteina PGC-1α, con conseguente aumento della capacità ossidativa delle fibre di tipo I e riduzione dell’accumulo di lattato. Inoltre, mantenendo un’intensità inferiore al 65% della VO2max, l’allenamento LISS minimizza la produzione di cortisolo e non interferisce con la sintesi proteica muscolare, risultando particolarmente indicato nei periodi di costruzione ipertrofica o nei giorni di recupero attivo.
2. Allenamento intervallato ad alta intensità (HIIT)
L’High Intensity Interval Training (HIIT) è caratterizzato da attività ad intensità superiore al 90% della frequenza cardiaca massima, intervallati da periodi di recupero completo o attivo. L’obiettivo principale è migliorare la potenza aerobica e la capacità glicolitica aumentando l’utilizzo dell’ossigeno anche in condizioni di intensità elevata (incremento della VO2max).
Dal punto di vista fisiologico, l’HIIT stimola in modo significativo sia il sistema anaerobico lattacido che quello aerobico, inducendo adattamenti cardiovascolari (incremento della gittata sistolica e della capillarizzazione muscolare) e metabolici (miglioramento del trasporto e dell’ossidazione degli acidi grassi). In ambito sportivo, risulta particolarmente utile negli sport misti o di potenza intermittente, in cui la capacità di ripetere sforzi esplosivi mantenendo un recupero rapido è determinante per la performance.
3. LISS o HIIT? La scelta in base al contesto calorico
La selezione del tipo di lavoro aerobico deve essere strettamente correlata allo stato nutrizionale e agli obiettivi specifici, poiché la disponibilità energetica condiziona in modo significativo la capacità di recupero e l’efficacia degli adattamenti neuromuscolari.
In un contesto di surplus calorico finalizzato all’ipertrofia o al miglioramento della forza:
- LISS è la scelta preferenziale, poiché migliora la capacità ossidativa e la densità mitocondriale con un impatto minimo sul sistema nervoso centrale (SNC) e senza interferire con la segnalazione anabolica mediata da mTOR. Camminate veloci o ciclismo leggero, 30-45 minuti al 55-65% della VO2max, 2-3 volte a settimana, sono ideali come recupero attivo.
- HIIT va usato con estrema moderazione, solo se necessario per mantenere la potenza aerobica o la tolleranza lattacida in sport misti. Sessioni troppo ravvicinate all’allenamento di forza possono ridurre l’efficacia del carico meccanico, aumentare il danno muscolare e incrementare la richiesta energetica per i processi di recupero, sottraendo risorse alla supercompensazione.
In deficit calorico, la priorità diventa mantenere la massa muscolare riducendo il più possibile l’impatto catabolico e lo stress sistemico:
- LISS è generalmente la strategia più sicura e sostenibile, soprattutto se l’obiettivo è preservare il SNC e non interferire con la qualità del lavoro in sala pesi. 30-60 minuti a bassa intensità possono essere inseriti nei giorni off o a fine seduta, contribuendo al dispendio calorico con un impatto minimo su cortisolo e sintesi proteica.
- HIIT va utilizzato con estrema cautela o limitato a brevi cicli specifici (ad esempio atleti agonisti in fasi finali di definizione), poiché l’elevata richiesta neuromuscolare e l’accumulo di fatica possono ridurre la qualità del lavoro con i pesi e aumentare il rischio di overreaching. L’EPOC elevato e la stimolazione catecolaminergica sono vantaggi interessanti, ma spesso il costo in termini di recupero non giustifica il beneficio in un organismo già in deficit energetico.
Recupero: l’allenamento invisibile
Allenarsi duramente è inutile se non si recupera adeguatamente.
Il recupero è il momento in cui il corpo ripara i tessuti, immagazzina glicogeno e attiva i meccanismi di supercompensazione. Senza di esso, l’allenamento diventa solo accumulo di fatica.
I pilastri del recupero efficace
Sonno
Dormire meno di 6 ore riduce significativamente la capacità di recupero, con una diminuzione stimata della sintesi proteica muscolare del 20-30% e un calo dei livelli di testosterone e IGF-1. Gli atleti dovrebbero garantire 7-9 ore di sonno continuativo di qualità, mantenendo orari regolari, un ambiente completamente buio e privo di stimoli elettronici per favorire un corretto rilascio di melatonina e GH.
Nutrizione mirata
Un recupero ottimale richiede un apporto proteico giornaliero di almeno 1,4 g/kg fino a 2,2 g/kg di peso corporeo per massimizzare la sintesi proteica. I carboidrati, assunti soprattutto nel post-allenamento, ripristinano le scorte di glicogeno e abbassano la tempesta citochinica (infiammazione). Un buon apporto di fibre (tra i 25 e i 35 g/die) e almeno 30-40 kcal/peso corporeo migliora l’eubiosi intestinale e garantisce un corretto ripristino delle scorte energetiche depletate durante il workout.
Gestione dello stress
Un cortisolo cronicamente elevato inibisce la sintesi proteica e accelera il catabolismo muscolare. Sapersi destreggiare tra le insidie della quotidianità e saper calcolare il corretto rapporto volume:recupero, può salvare la vita.
Inoltre, tecniche quali respirazione diaframmatica lenta, meditazione guidata o brevi pause attive riducono l’attivazione del sistema simpatico, favorendo un migliore equilibrio ormonale e un sonno più profondo.
Attività leggere come stretching, yoga o camminate a ritmo moderato favoriscono il ritorno venoso, migliorano la perfusione muscolare e accelerano l’eliminazione dei metaboliti (lattato e ioni idrogeno), contribuendo a ridurre la rigidità muscolare senza sovraccaricare il sistema nervoso.
Errori comuni da evitare
1. Allenarsi sempre al limite
Non fraintendete! L’intensità fa parte dello sportivo sin dai tempi più antichi! Sappiate però esser saggi e abbiate a cuore la longevità!
L’eccessivo accumulo di fatica neurale e muscolare riduce la capacità di reclutare fibre ad alta soglia, può alterare l’equilibrio ormonale (incremento cronico del cortisolo, riduzione di testosterone e IGF-1) e compromettere i processi di supercompensazione. Alternare settimane di scarico attivo o riduzione del volume/intensità risulta fondamentale per garantire adattamenti progressivi e sostenibili.
2. Sottovalutare il ruolo dell’alimentazione nei giorni off
Ridurre l’apporto calorico nei giorni di riposo, credendo di “consumare meno calorie”, può essere una trappola per alcune persone. In realtà, è proprio durante queste giornate che avvengono i principali processi di riparazione tissutale e sintesi proteica, che richiedono una disponibilità adeguata di aminoacidi, carboidrati per il ripristino del glicogeno e micronutrienti chiave (zinco, magnesio, vitamine del gruppo B). Questo però non significa che bisogna mangiare di più nei giorni di riposo, ma piuttosto calibrare la quota calorico-proteica in relazione a: stanchezza percepita, DOMS percepiti, fame percepita, stile di vita. Ci saranno quindi soggetti che apprezzeranno uno scarico calorico, altri che manterranno l’introito alimentare dei giorni di allenamento e altri ancora che preferiranno mangiare di più nei giorni di riposo piuttosto che in quelli di allenamento.
3. Confondere stanchezza con allenamento efficace
La sensazione di essere “distrutti” a fine seduta non è sinonimo di progresso. L’accumulo eccessivo di fatica periferica e centrale può ridurre la qualità del lavoro nelle sedute successive, rallentando i miglioramenti. Un allenamento efficace è quello che genera stimolo sufficiente ma gestibile, consentendo di mantenere intensità e tonnellaggio medio-alti nel lungo periodo.
Take Home Message
Un atleta che ignora il recupero è paragonabile a una supercar con un motore da 600 cavalli, ma con serbatoio quasi vuoto e pneumatici usurati: può sprigionare potenza per qualche secondo, ma è destinata a fermarsi presto.
La vera performance non è la capacità di spingere forte una volta sola, ma l’abilità di ripetere gesti intensi nel tempo. Significa allenarsi con costanza per mesi, riducendo al minimo il rischio di infortuni, gestendo correttamente i carichi e rispettando i processi di supercompensazione.
Solo così i progressi diventano realmente sostenibili e cumulativi.
Bibliografia
- Granata C. & Jamnick N. A. Training-induced improvements in mitochondrial respiration and endurance performance: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 2018.
- Hackney K. J. et al. Endurance training enhances resistance training adaptations: potential mechanisms. Sports Medicine, 2019.
- Bongiovanni T. et al. Sleep and athletic performance: The effects of sleep loss on exercise performance, and physiological and cognitive responses to exercise. Sports Medicine, 2020.
- Halson S. L. Monitoring training load to understand fatigue in athletes. Sports Medicine, 2014.
- Grgic J. et al. The effect of aerobic training on muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, 2019.
Dott. Nicola Frisoni